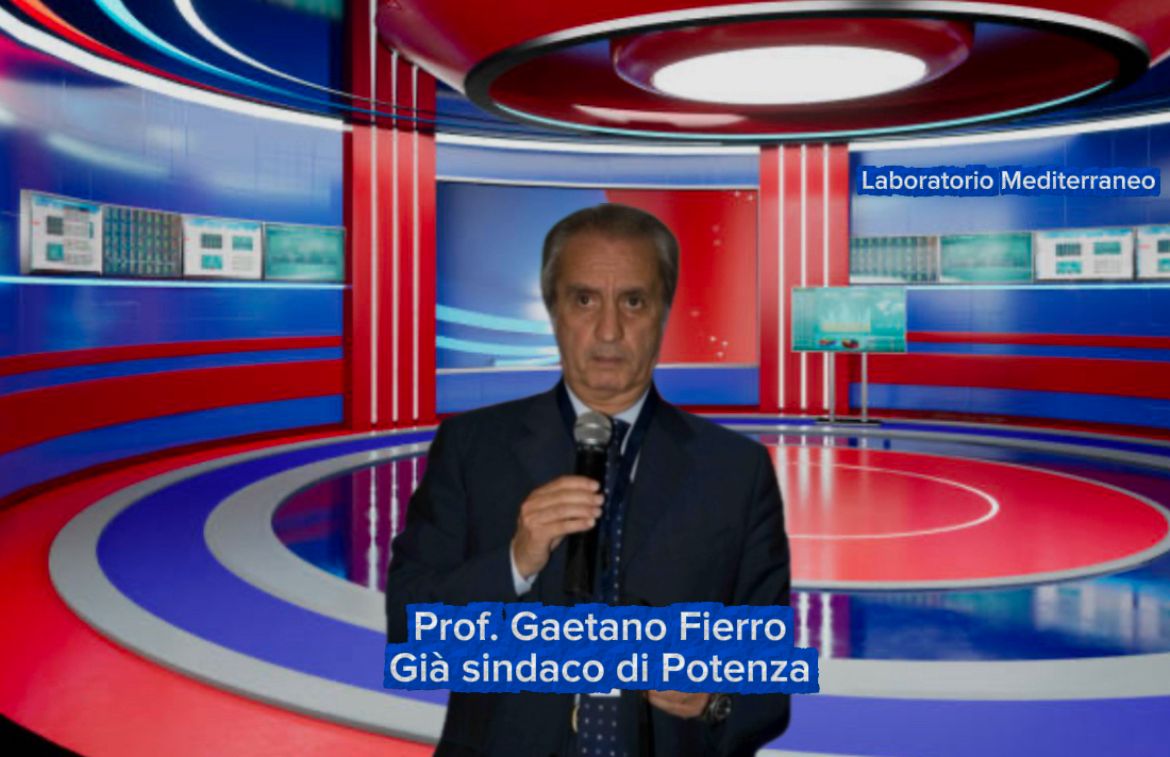La Basilicata, o Lucania, nel suo nome più antico, si trova nel cuore geografico del Mediterraneo centrale. Tra Tirreno e Ionio, tra l’Italia
e i Paesi della sponda sud, la regione può trasformare
la sua posizione di “terra interna” in un vantaggio strategico. Oggi l’Europa, con il “Patto per il Mediterraneo. Un mare, un patto, un futuro”, chiede agli Stati membri di costruire nuove relazioni tra Nord e Sud del mare comune, fondando
la cooperazione su tre pilastri: persone, economia sostenibile e interconnessa, sicurezza e gestione dei flussi migratori.
Riprendendo il libro di Dino Nicolia “La strategia euromediterranea: prospettive politico-economiche per il Mezzogiorno” che, pubblicato 20 anni fa con la FrancoAngeli di Milano, ha costituito la base del pensiero che pone il Mezzogiorno al centro del Mediterraneo, mi accingo ad analizzare una serie di aspetti per dimostrare che la Lucania ha risorse e potenzialità che, se coordinate, possono renderla un modello di sviluppo intelligente e un nodo della nuova università e diplomazia mediterranea.
Il primo pilastro del Patto invita alla nascita di una “Università del Mediterraneo”,
con campus distribuiti tra le città delle due sponde.
La Università degli Studi della Basilicata (UniBas) e la città di Matera, già Capitale Europea della Cultura nel 2019,
rappresentano un punto di partenza concreto per ospitare un Campus Euro-Mediterraneo. Gli obiettivi operativi sarebbero i seguenti:
• creare corsi di laurea e master in lingua inglese e araba su ambiente mediterraneo, energia, migrazioni, archeologia, diplomazia culturale;
• avviare summer school internazionali e laboratori
di coesione che coinvolgano studenti di Tunisia, Egitto, Marocco, Libano, Israele, Giordania;
• sviluppare, in collaborazione con la Fondazione Anna Lindh e la Commissione Europea, un Centro lucano per il dialogo mediterraneo, ospitato a Matera o Potenza, come nodo del futuro network accademico.
Un progetto di questo tipo darebbe alla Lucania visibilità internazionale, ma soprattutto riporterebbe la cultura e la ricerca al centro delle politiche territoriali, in coerenza con lo spirito del Patto europeo.
Il secondo pilastro del Patto si fonda su un’economia sostenibile e interconnessa.
La Lucania è già oggi un laboratorio naturale di transizione ecologica e di bioeconomia:
• nel Basilicata Open Lab, ENI, Università e start-up locali sperimentano innovazioni nei settori energia, mobilità sostenibile e agritech;
• l’Aglianico del Vulture, le produzioni di olio e cereali di collina, la filiera ortofrutticola ionica dimostrano la vitalità di un’agricoltura mediterranea ad alto valore aggiunto;
• il Parco nazionale dell’Appennino Lucano, insieme ai Parchi del Pollino e della Murgia Materana, è un laboratorio di biodiversità e di turismo ambientale. Per inserirsi nel Patto, la Lucania può proporsi come:
• regione pilota per la bioeconomia mediterranea, sperimentando filiere integrate tra agricoltura, energia e turismo sostenibile;
• sede di un polo di ricerca sull’agricoltura resiliente mediterranea, con partenariati Nord-Sud finanziati dai fondi UE (Horizon Europe e Neighbourhood Instrument);
• centro per start-up
e spin-off green promossi da studenti e ricercatori provenienti dalle sponde del Mediterraneo.
Questa visione economica non è solo ecologica, ma culturale: un’economia che nasce dalla conoscenza, non dallo sfruttamento.
Il terzo pilastro del Patto riguarda sicurezza e gestione dei flussi migratori. La Lucania, pur non essendo una regione di sbarchi, può offrire un modello di accoglienza e dialogo interculturale fondato sulla formazione. L’idea è di costruire a Matera o Potenza un Centro mediterraneo per la diplomazia territoriale,
che formi giovani funzionari, operatori culturali e mediatori linguistici provenienti da Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Programmi congiunti con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con l’Università di Tunisi, o con l’Università di Rabat potrebbero trasformare la Lucania in una vera “palestra di dialogo” mediterranea, in grado di generare competenze pratiche nella mediazione e nella cooperazione.
Questo approccio è coerente con quanto denunciato dal diplomatico statunitense Aaron Wess Mitchell su Foreign Affairs: “la crisi della diplomazia deriva dall’averla ridotta a tecnica senza cultura”. La Lucania può contribuire a restituire alla diplomazia quella dimensione umanistica che nasce dal contatto tra persone e luoghi.
Il potenziale è grande, ma non automatico. Perché la Lucania diventi davvero un nodo del Mediterraneo, occorre affrontare alcune criticità strutturali:
• Infrastrutture e connessioni ancora insufficienti, specie nei collegamenti ferroviari
e aeroportuali;
• debolezza del sistema universitario, che deve internazionalizzarsi e potenziare la ricerca;
• fuga dei giovani laureati, che rischia di svuotare di senso qualunque progetto a lungo termine;
• scarso coordinamento istituzionale tra Regione, Università, Comuni e sistema produttivo. Servono quindi governance e visione.
Il rischio da evitare è quello
di un “Mediterraneo di carta”, un contenitore burocratico senza anima né risultati.
Per passare dalle intenzioni ai fatti, la Regione Basilicata può adottare un Piano d’Azione Lucano per il Mediterraneo (PALM), articolato su cinque direttrici operative:
1. Istituzione del “Campus Mediterraneo Basilicata”
Un polo universitario diffuso (Potenza, Matera, Metaponto) collegato all’Università del Mediterraneo, con corsi trilingue (italiano, inglese, arabo) e programmi di mobilità integrata.
2. Creazione del “Centro Lucano per la Diplomazia Mediterranea”. Un centro studi e formazione dedicato alla cooperazione, alle politiche migratorie, alla governance mediterranea, in partnership con la Fondazione Anna Lindh e il MAECI.
3. Programma “Basilicata Green Med”. Coordinamento dei progetti di energia, agricoltura sostenibile, turismo ambientale e start-up in un unico pacchetto di sviluppo, coerente con il secondo pilastro del Patto.
4. Tavolo Mediterraneo Basilicata–Africa. Una piattaforma di collaborazione tra imprese lucane, università e partner africani e mediorientali per lo scambio di tecnologie, prodotti e formazione.
5. Campagna “Lucania Porta del Mediterraneo”. Un piano di comunicazione e attrazione turistica e accademica internazionale che racconti la Basilicata come “regione-ponte” del nuovo umanesimo mediterraneo. Queste azioni possono essere cofinanziate tramite fondi europei 2026-2030: Erasmus+, Horizon Europe, NDICI (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument), e i programmi
del Piano Mattei per l’Africa.
La sfida per la Lucania
è quella di superare la logica dell’attesa e assumere la logica della proposta.
In un Mediterraneo che si prepara a riscrivere le proprie relazioni, la Lucania può essere la regione che dialoga, studia e sperimenta, non solo che osserva. Non servono promesse miracolistiche per un nuovo umanesimo lucano,
ma il coraggio di mettere insieme le competenze esistenti, università, impresa, cultura, in una visione che unisca sapere e sviluppo. Se la Lucania saprà farsi interprete del Patto europeo non come beneficiaria,
ma come soggetto attivo, potrà finalmente passare da periferia geografica a centro culturale del Mediterraneo.
Un piccolo territorio con un grande compito: dimostrare che la cultura, la conoscenza e il dialogo possono ancora cambiare il destino di un Paese e di un mare.
Lucania, laboratorio mediterraneo d’Europa di Gaetano Fierro